 S. Giovanni Battista decollato, Santuario della Madonna Addolorata (Chiesa e santuario, Tuscania)
S. Giovanni Battista decollato, Santuario della Madonna Addolorata (Chiesa e santuario, Tuscania)
Sita nel centro storico, è citata fin dal 1221, in origine dedicata a Santa Maria Nuova; cambia nome in San Giovanni quando diviene sede dell’omonima confraternita.
Ristrutturata nel XIX secolo. La facciata è semplice, con portale architravato e sormontato da un rosone ottagonale mentre il timpano è retto da paraste di ordine tuscanico. All’interno, a navata unica, si possono osservare un crocefisso e, sull’altare maggiore, la Decollazione del Battista e la volta della cappella a sinistra è decorata con un bel cielo stellato[1].
La Madonna Addolorata. La storia della devozione alla Vergine Addolorata ha inizio nell’Ottocento. Un nobile tedesco della famiglia Nodoler, giunto a Tuscania, conosce una ragazza della famiglia degli Eusepi, se ne innamora e la fa sua sposa. Nel loro viaggio di nozze, visitando un convento di frati, nella Alsazia, i due sposi restano colpiti da una scultura, eseguita da un ignoto frate. I Nodoler acquistano la scultura e, al loro rientro in Italia, la portano a Tuscania. L’immagine, vestita di nero, viene posta in una stanza della casa degli Eusepi, che, da quanti la visitano, è chiamata la stanza della Madonna.
L’Immagine, venerata in luogo non consacrato, incomincia ad elargire grazie e la casa degli Eusepi diviene luogo di pellegrinaggio di malati e di sofferenti, tanto che i coniugi Nodoler decidono di farne dono alla Parrocchia di San Giovanni Decollato (affidata alla Confraternita della Misericordia di cui Cristoforo Nodoler era priore) dove fanno realizzare una cappella che sarà terminata nel 1839. A partire da quella data, o negli anni immediatamente precedenti, nasce la tradizione di portare in processione la statua. La prima macchina adibita per il trasporto, che oggi non esiste più, riportava la data 1845.
La devozione alla Madonna Addolorata. In passato la statua era portata a spala da sedici uomini scelti tra i membri della Confraternita della Misericordia, vestiti con tuniche bianche chiuse alla vita da un cordone nero. Questo numero rimane fisso a sedici fino al 1936. Fino a quella data infatti, il ruolo di Araldo veniva tramandato esclusivamente all’interno della famiglia a cui apparteneva la persona che era costretta a lasciare l’incarico. Questa usanza comincia a venir meno dopo la fine della Seconda Guerra mondiale: per poter soddisfare l’alto numero di richieste di fedeli devoti che volevano ricoprire questo ruolo, il numero degli Araldi cominciò ad aumentare sensibilmente. Nel corso dei trasporti il numero dei facchini arrivò a raggiungere il centinaio, a testimoniare la profonda devozione verso la Vergine.
A partire dal 1950 la loro divisa cambia in quella attuale, più pratica e adatta al trasporto della ingombrante veste usata prima: pantaloni scuri, camicia bianca sulla quale spicca, in alto a sinistra, un cuore trafitto da sette spade. Nel 1972 viene costituita l’attuale Associazione degli Araldi dell’Addolorata che riunisce coloro che partecipano alla processione portando a spalla il trono e tutti coloro che l’hanno trasportata in passato[2]
Nel 2022, in occasione del centenario dell’incoronazione della Madonna Addolorata, la chiesa è stata innalzata a santuario diocesano dell’Addolorata.
All’interno, oltre all’Altare maggiore con il dipinto della Decollazione di S. Giovanni battista, sono presenti:
La cappella di S. Ubaldo. L’altare di S. Ubaldo era amministrato dai mercanti della lana che ogni mese vi faceva celebrare la messa. Era eretto nella parete destra, aveva una immagine dipinta su tela, di pertinenza dei Mercanti della Lana di Gubbio[3]. Nella visita pastorale del 1708 l’altare di s. Ubaldo è in cattive condizioni e, nel corso del Settecento, sarà dedicato anche a s. Omobono (protettore dei sarti e dei mercanti di stoffe)[4]. Probabilmente coinvolto nei danni subiti dalla chiesa a causa del terremoto del 1695 e il successivo del 1703 e interessato dai diversi lavori di ristrutturazione attuati nella chiesa nel secolo XVIII, cambia forma e intitolazione[5]. Nel 1732 l’altare è abbellito da un’icona dipinta e assegnato all’Arte dei Calzolai e nel 1744 compare la dedica anche a S. Carlo[6]. Il culto sull’altare di S. Ubaldo/Omobono, nel 1785, risulta sospeso in quanto nessuno se ne accolla più l’onere, mentre compare per la prima volta l’altare della Madonna dei Sette Dolori. Non si esclude che la cornice del quadro di S. Omobono sia andato a racchiudere l’immagine della Madonna del Triponte[7]
La cappella di S. Antonio di Padova. Sembra che in origine, la cappella fosse dedicata al culto della Madonna del Triponte, ovvero Madonna della Salute (nel 1393 è documentata una cappella con questo nome), della quale resta l’immagine ad affresco nella parete di fondo[8]. Maria Luisa Sili descrive l’altare di S. Antonio di Padova, datato al sec. XVII, stato realizzato in nefro probabilmente da un artigiano locale.
La Cappella del Crocifisso. Nella parete di destra, testimonianza di una precedente fase edilizia dell’edificio, si trova un dipinto realizzato ad olio su muro che è ciò che rimane dell’altare del SS.mo Crocifisso, eretto nella prima metà del Seicento, e del quale si conosce anche il nome del committente “eretto a spese del fu Lorenzo Venanzi”[9].
La cappella della Madonna Addolorata. A destra della navata centrale, sopra l’altare in marmi policromi, è conservato il simulacro della Madonna Addolorata, collocato all’interno di una nicchia incorniciata di marmo e sormontata da un festone di fiori in stucco dorato che scende anche lungo i lati.
(fonte “Gente di Tuscia” – https://www.gentedituscia.it/s-giovanni-battista-decollato-chiesa-e-santuario-tuscania/


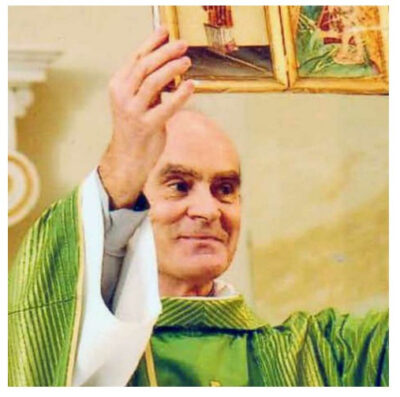 Era nato a Piansano il 13 settembre del 1951, figlio di Alfredo e di Angela Del Signore. Il padre era un muratore, attività poi proseguita insieme ad uno dei figli. Dopo le scuole elementari frequentate a Piansano, “All’età di 11 anni iniziò il suo cammino formativo tra i Fratelli delle Scuole Cristiane, dove, dopo la Professione solenne, si dedicò per tanti anni all’insegnamento dei piccoli e dei giovani, in varie Scuole dell’Ordine in diverse parti d’Italia, nello spirito del carisma di san Giovanni Battista De La Salle.
Era nato a Piansano il 13 settembre del 1951, figlio di Alfredo e di Angela Del Signore. Il padre era un muratore, attività poi proseguita insieme ad uno dei figli. Dopo le scuole elementari frequentate a Piansano, “All’età di 11 anni iniziò il suo cammino formativo tra i Fratelli delle Scuole Cristiane, dove, dopo la Professione solenne, si dedicò per tanti anni all’insegnamento dei piccoli e dei giovani, in varie Scuole dell’Ordine in diverse parti d’Italia, nello spirito del carisma di san Giovanni Battista De La Salle. S. Giovanni Battista decollato,
S. Giovanni Battista decollato,  Ubicata in un quartiere moderno della cittadina di Tuscania denominato Villaggio Gescal, la chiesa della Nostra Signora di Lourdes sorge isolata al centro di piazza Padre Pio da Pietralcina che si apre all’angolo tra via Tuscia e via Nostra Signora di Lourdes.
Ubicata in un quartiere moderno della cittadina di Tuscania denominato Villaggio Gescal, la chiesa della Nostra Signora di Lourdes sorge isolata al centro di piazza Padre Pio da Pietralcina che si apre all’angolo tra via Tuscia e via Nostra Signora di Lourdes.
 1968 (costruzione della chiesa intero bene)
1968 (costruzione della chiesa intero bene) Pianta
Pianta